Antonio Canova (nato il 1 novembre 1757) morì a Venezia il 13 ottobre 1822, mentre era a casa di un suo amico , in una tappa del suo viaggio intrapreso per far ritorno a Roma.
Il tempio sepolcrale che custodisce le sue spoglie è a Possagno, in provincia di Treviso, suo paese di nascita dove egli stesso, alcuni anni prima di morire, nel 1819, progettò personalmente e fece costruire a sue spese Il tempio.
Il suo cuore è conservato all’interno del cenotafio che i suoi allievi, gli vollero dedicare a Venezia, in Santa Maria Gloriosa dei Frari.
La casa natale di Antonio Canova è oggi diventata a Possagno un museo “particolare” che raccoglie la pinacoteca dell’artista veneto, alcuni disegni, le incisioni delle opere e numerosi cimeli. Accanto alla casa, sorge la maestosa Gipsoteca canoviana, un enorme edificio a forma basilicale, voluto dal fratellastro dell’Artista, ed unico erede, Giovanni Battista Sartori, e progettato (1836) dall’architetto veneziano Francesco Lazzari (1791-1871) per raccogliere i preziosissimi modelli in gesso, i bozzetti in terracotta, alcuni marmi che si trovavano nello studio dell’artista a Roma al momento della sua morte.
La Gipsoteca canoviana fu ampliata nel 1957, nell’occasione delle celebrazioni del duecentesimo anniversario della nascita dell’Artista, con una nuova addizione, progettata dall’architetto veneziano Carlo Scarpa (1906-1978). Un’opera magnifica in cui scultura ed architettura, si fondono nella luce, che abilmente lo Scarpa, ha saputo magistralmente gestire, per valorizzare al massimo le opere di Canova. I pavimenti degradano leggermente, quasi a seguire l’andamento naturale del terreno, la pianta è a forma di cuneo e si insinua tra la Gipsoteca esistente, gli angoli del soffitto sono smaterializzati per divenire degli “occhi di luce”. Gli intonaci chiari sono trattati per sembrare ruvidi e grezzi, quasi a contrastare la bianca lucidità delle opere scultoree canoviane. Dettagli “estremi” ed azzardati, frutto di elucubrazioni sofisticate di un sapiente dell’archi-scultura, praticata da Scarpa, molto prima di chiunque altro, difatti l’edificio fa acqua dappertutto : dal tetto, dai serramenti, ecc.. D’altronde chi fa ricerca ed innovazione linguistica, in architettura, rischia molto. La Gipsoteca Canoviana di Possagno (Treviso) è uno di quei posti assolutamente da visitare, perchè permeato dovunque della “magia dell’architettura intelligente”.
http://www.museocanova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=62&lang=it
La raccolta delle centinaia di gessi conservati nella Gipsoteca di Possagno consentono di restituire il duro lavoro, meticoloso e gravoso che Canova profondeva nelle sue opere, e che ne hanno fatto un maestro assoluto. Le statue infatti non nascevano quasi mai dalla lavorazione intuitiva del marmo, ma dopo un metodico e precisissimo studio, dal disegno all’argilla, dal gesso al marmo. Il modello in gesso, in particolare, veniva realizzato con una colata su un “negativo” ricavato dalla precedente opera in argilla; nel gesso venivano applicati una miriade di chiodini di bronzo, tuttora visibili nelle statue di Possagno, che consentivano con un apposito e sofisticato pantografo, di trasferire le misure e le proporzioni del gesso nel marmo.
Inoltre Canova lavorava in “simbiosi” con i suoi collaboratori, che inizialmente sbozzavano la scultura, poi lui di persona, la rifiniva, con gli ultimi ritocchi, levigando e dando la forma con le “azioni” più adatte. Le sculture sembrano vere perché impregnava la spugna nell’acqua del secchio con i suoi strumenti sporchi la passava sul marmo poroso ed infine ci metteva la cera dando così il colore dell’incarnato.
Nel giardino davanti alla casa, tuttora coltivato secondo le modalità e con le essenze arboree del tardo Settecento, vive ancora oggi una grande Pino italico (Pinus Pinea), piantato dallo stesso Canova nel 1799.
Con il rispetto del copyright delle immagini selezionate











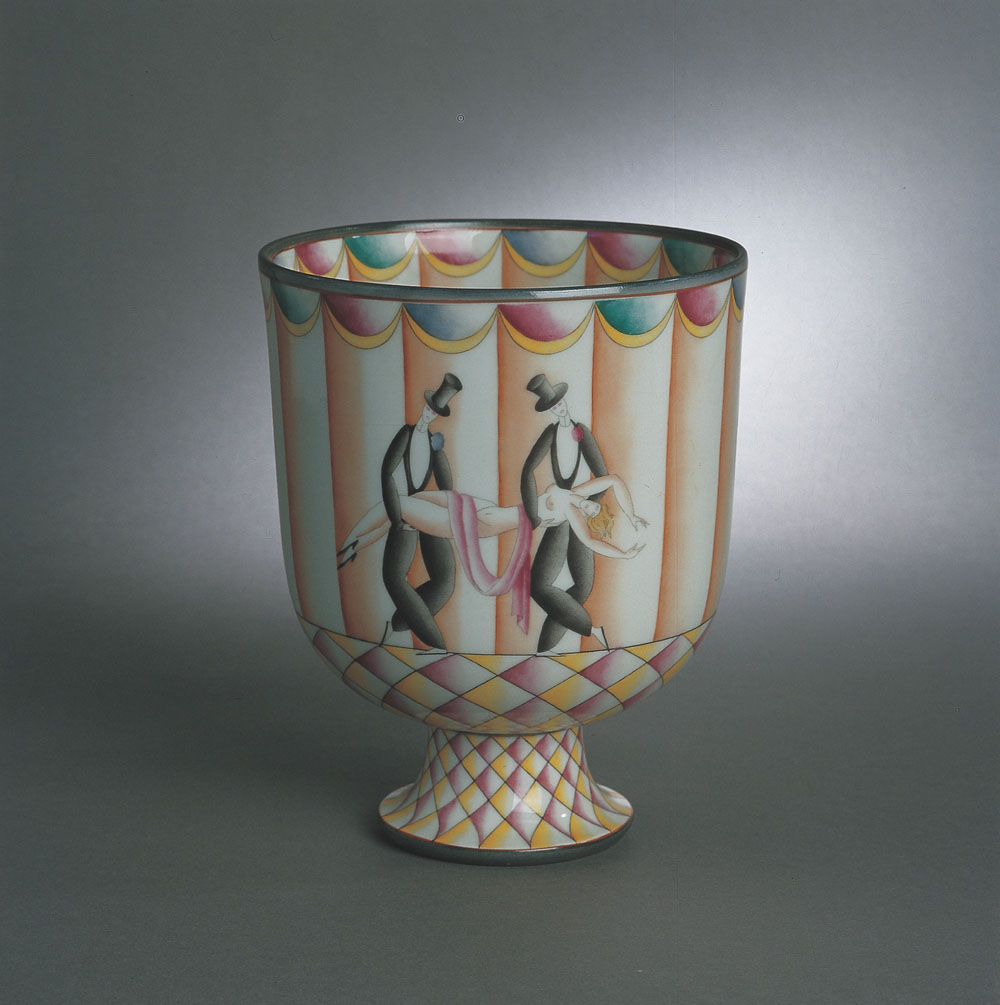


Lascia un commento